Negli ultimi mesi e giorni mi sono trovata, come persona, come paziente ed infine come infermiera, ad osservare da vicino quanto sia ancora fragile e distorta la percezione della mia professione, soprattutto quando esce dal mero ambito tecnico-esecutivo.
Alcuni accadimenti recenti mi hanno reso molto evidente qualcosa che in realtà esiste da sempre: una difficoltà culturale profonda nel riconoscere all’infermieristica la sua piena competenza nella relazione d’aiuto, nell’educazione, nella gestione dell’essere umano a 360 °.
Parlo di come viene vista, interpretata e quasi sempre, ridotta.
Di quanto, pressoché sempre, una parte fondamentale della nostra competenza venga ignorata, svalutata o semplicemente non riconosciuta, anche all’interno di contesti che per loro stessa natura e senso dovrebbero conoscerla meglio.
Non mi riferisco a singoli episodi.
Parlo di un problema sistemico.
Ed è per questo che ho sentito il bisogno di scrivere questo articolo: non per raccontare una storia personale o come sfogo ma come atto di chiarezza, per aprire una riflessione collettiva, anche dentro la categoria stessa, che invito al dialogo.
Scrivo dunque questo articolo per tutti.
Ma in questo caso, soprattutto per i colleghi infermieri.
Come appello a ricordare chi siamo davvero e quale peso reale regge la nostra professione. Se non lo facciamo noi, non possiamo pretenderlo da chicchessia…
Dico questo perché credo che una delle fragilità più grandi della nostra professione non venga dall’esterno, ma da una visione riduttiva che, magari inconsapevolmente, continuiamo a portare avanti noi in primis.
Quante volte, nel confronto tra colleghi, ho chiaramente colto una ferita attiva rispetto la loro percezione di una marcata differenza di riconoscimento e di rispetto attribuita ad altre professioni sanitarie (fisioterapisti, nutrizionisti, logopedisti e compagnia cantante) nonostante i percorsi universitari siano comparabili per durata, impegno e responsabilità!
Per quasi vent’anni la mia vita professionale è stata immersa nella parte più visibile e nota dell’assistenza: emergenza, procedure, rapidità, precisione.
Era necessario. Era ciò che serviva.
Lì l’infermiere è chiamato a fare, e a fare bene.
Tuttavia, MAI ho dimenticato, anche in quel contesto, che dietro ad un paziente, vi fosse un umano come me, multidimensionale ed intero, meritevole del fatto che io non me ne dimenticassi in nessun momento.
Poi, lavorando nelle cure palliative, ho approfondito ancora di più anche le altre dimensioni.
Non opposte eh. Solo priorità un po’ diverse.
Ho ricordato in modo chiaro, inequivocabile e profondamente impattante su di me che l’infermieristica non è “tecnica applicata al corpo”, ma più di ogni altra cosa, è Presenza. Applicata all’assistenza dell’essere umano.
Che la relazione d’aiuto non è un’aggiunta opzionale, ma la competenza centrale. (da cui peraltro nasce come professione!)
Che stare accanto a chi soffre, a chi ha paura, a chi sta morendo, richiede una qualità professionale che non ha nulla di improvvisato.
Eppure questa parte del nostro lavoro continua ad essere sistematicamente ignorata.
Dalla cultura collettiva.
Dalle istituzioni.
A volte (e a mio avviso troppo spesso), perfino da noi professionisti stessi.
L’infermiere viene ancora raccontato come “quello che esegue”, “quello che applica procedure e protocolli”, “quello che fa le flebo”.
Come se la relazione, l’ascolto, la gestione emotiva non fossero competenze professionali, ma tratti caratteriali casuali.
E invece no.
La relazione d’aiuto non è psicoterapia.
Non è trattamento clinico della psiche.
Non è diagnosi.
È la capacità di “Stare”.
Di supportare un altro essere umano.
Di accompagnare con discrezione.
Di sostenere senza sostituirsi.
Di aiutare la persona a restare integra anche nella più straziante fragilità.
Negli anni ho scelto di approfondire proprio questa dimensione: ho studiato psicologia, ho assiduamente lavorato e ricercato nell’ambito dell’educazione interiore, dell’intelligenza emotiva applicata, della presenza consapevole, dell’autoregolazione attraverso il corpo ed il respiro.
Non per “diventare altro”.
Ma per diventare più infermiera.
Per questo sento il bisogno di dirlo con chiarezza, anche per chi, tra i colleghi, si sente in bilico o poco riconosciuto:
io non sono “un’infermiera che fa mindfulness”.
Sono un’infermiera che partendo da basi neuroscientifiche ha scelto di lavorare sull’educazione all’autoregolazione, sulla competenza emotiva e sulla capacità della persona di restare presente a sé stessa anche nella fragilità.
Questo non è sconfinare.
È un’altra cosa.
È prendersi cura.
È accompagnare l’essere umano a non perdere sé stesso mentre attraversa il dolore, lo stress, la malattia, il limite.
È una competenza infermieristica. E fa pesantemente parte integrante della formazione.
Solo che non fa rumore.
E forse il sistema non è ancora pronto a leggerla.
Ma questo non la rende meno vera.
Perché un infermiere che sa regolarsi, che sa leggere le emozioni, che sa stare nel disagio senza irrigidirsi o fuggire, è un professionista più solido.
Più sicuro.
Più utile.
In definitiva, più completo.
Il paradosso è che oggi queste competenze vengono accolte senza problemi in contesti olistici, aziendali o motivazionali (senza alcuna formazione sanitaria) mentre vengono guardate con sospetto quando a portarle è un’infermiera. (E mi è accaduto personalmente)
Questo dice molto.
Non di chi lavora seriamente ovviamente.
Ma della povertà culturale con cui, ancora oggi, viene letta la professione infermieristica — talvolta persino da chi si definisce “addetto ai lavori”.
Forse è il momento di dirlo chiaramente:
L’infermieristica non è subordinazione tecnica.
Non è solo “fare quello che prescrive il medico”.
Non è solo protocollo.
È CURA.
E la cura include tutto il pacchetto: il corpo, le emozioni, la presenza, la relazione.
Finché continueremo a ridurci da soli a “quelli che fanno le iniezioni”, non potremo lamentarci se il mondo ci vede così.
Ma se iniziamo ad onorare TUTTA la nostra competenza, anche quella che non si certifica con un “distintivo” in più perché è parte integrante della nostra formazione, allora qualcosa può cambiare. E lo dobbiamo volere noi per primi, che conosciamo bene il prezzo di questa multidimensionalità assistenziale.
Questo non è un attacco.
È un invito. Magari un po’ provocatorio….
È una chiamata in causa per i colleghi e per chiunque abbia voglia di aprire un dialogo rispettoso ed educato.
Perché è tempo di guardare l’infermieristica per ciò che è davvero.
La professione che, senza far rumore, regge un peso grande: l’essere umano a 360°.
L’infermieristica non ha bisogno di diventare altro per essere autorevole.
Ha bisogno di ricordarsi chi è. Un po’ come tutti gli umani…
È la professione che educa all’autonomia, non alla dipendenza.
Che accompagna promuovendo le risorse della persona.
Che sostiene senza valicare i confini.
È la professione che lavora perché la persona possa tornare a sentire, comprendere e regolarsi, anche nei momenti più difficili.
Questo è profondamente infermieristico.
Anche quando il sistema culturale non lo riconosce.
E forse, proprio per questo, è tempo che chi lo sente vero smetta di abbassare la voce.
Non per fare rumore.
Ma per dare forma e dignità ad una cura più intera, più onesta, più umana.
Sempre con Amore.
Monica
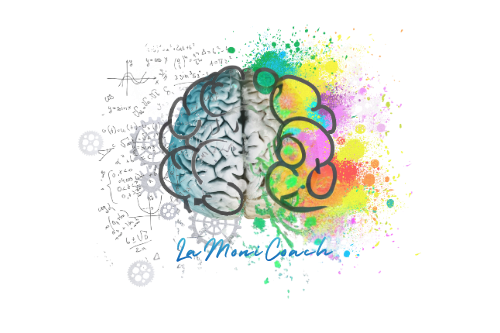

Lascia un commento